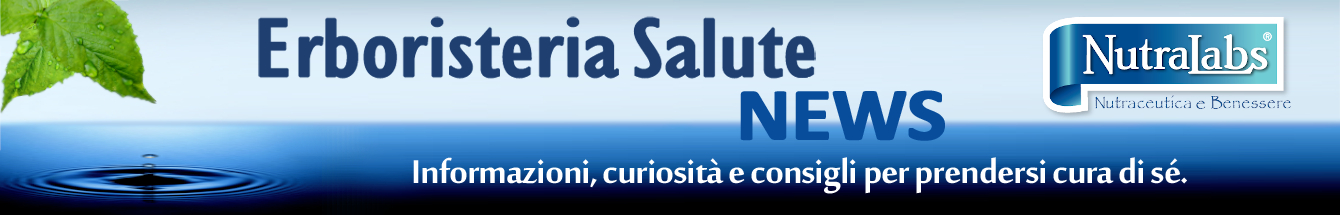Il cortisolo è considerato l’ormone dello stress per eccellenza. Infatti in condizioni di stress, a seguito dell’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, i livelli di questo ormone aumentano: una reazione che l’organismo mette in atto per mobilitare l’energia necessaria per far fronte allo stress (vedi QUI cos’è l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e come funziona la risposta di stress).
Ma questo eccesso di cortisolo, se nel breve periodo ha la funzione positiva di aiutarci ad affrontare una situazione difficile, a lungo andare esercita effetti negativi su molti aspetti della nostra fisiologia. Tra questi, i più preoccupanti sono forse quelli a livello metabolico e nervoso. Infatti situazioni di stress cronico, associate a livelli di cortisolo costantemente elevati per lunghi periodi di tempo, promuovono lo sviluppo di insulino-resistenza, obesità, ipertensione e di conseguenza di diabete e patologie cardiovascolari, e tendono a deteriorare le funzioni cognitive e l’anatomia stessa del cervello aumentando il rischio di malattie neurodegenerative (vedi tutti gli effetti dello stress sul corpo).
Lo stress cronico può però avere un esito del tutto opposto, e cioè attenuare l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e ridurre i livelli di cortisolo al di sotto dell’ottimale. Le conseguenze di questa situazione, pur se forse non pericolose come quelle opposte, possono tuttavia impattare in modo più o meno importante la qualità di vita, fino a creare condizioni realmente debilitanti.
Il cortisolo, ormone dello stress ma non solo
Il cortisolo è un ormone di straordinaria importanza, che controlla gran parte della nostra fisiologia. Tra le sue funzioni principali c’è quella di direttore d’orchestra del metabolismo: fa aumentare i livelli ematici di glucosio e di acidi grassi mobilitandoli dalle nostre riserve, in modo da consentire una maggior produzione di energia. È anche il nostro più potente antinfiammatorio endogeno, necessario affinché l’infiammazione che il corpo scatena per difendersi dalle aggressioni esterne non sfugga di mano, provocando danni, e si spenga quando non è più necessaria.
La sua funzione di attivare l’organismo, a livello sia fisico che mentale, dà conto del fatto che i livelli di cortisolo nel sangue mostrano sostanziali fluttuazioni durante la giornata, seguendo un marcato ritmo circadiano. Sono infatti minimi nelle ore serali, cominciano a salire a metà notte in modo da raggiungere valori elevati di prima mattina, hanno poi un ulteriore picco nei 30-45 minuti successivi al risveglio (un caratteristico fenomeno chiamato “risposta del cortisolo al risveglio”), dopodiché durante il resto della giornata tendono gradualmente a diminuire.
Questo andamento presenta comunque importanti variazioni individuali, con una forte base genetica e su influenza anche delle esperienze di vita precoci, che regolano la sensibilità dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene in modo duraturo. E anche nella stessa persona cambia di giorno in giorno in base alle esperienze fisiche, emotive, sociali che si presentano. In condizioni normali la percezione (o anche solo l’anticipazione) di una circostanza difficile o semplicemente di un impegno causa un incremento del cortisolo. È ben noto infatti che in situazioni di stress la secrezione di questo ormone aumenta, ma è stato osservato anche, per esempio, che la risposta del cortisolo al risveglio è maggiore nei giorni lavorativi rispetto al fine settimana, e che, se durante la giornata sperimentiamo emozioni negative come tristezza, paura o incapacità di far fronte agli impegni, la mattina successiva i livelli di cortisolo saranno maggiori.
Non dobbiamo quindi vedere l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene come un interruttore che ha solo la posizione acceso (in caso di stress) o spento (in caso di tranquillità). Si tratta invece di un sistema estremamente raffinato e sensibile che istante per istante adatta il funzionamento dell’organismo alle richieste dell’ambiente, da quelle più normali e quotidiane a quelle più estreme.
O, almeno, è quel che dovrebbe fare.

Quando il cortisolo è troppo basso
Può però accadere che, in misura maggiore o minore, l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene perda la propria sensibilità e diventi iporesponsivo. I livelli di cortisolo non si abbassano tanto da mettere a rischio il funzionamento di base dell’organismo o addirittura la sopravvivenza come accade nella malattia di Addison, in cui un processo autoimmune distrugge le ghiandole surrenali riducendo in modo drastico la loro capacità di produrre ormoni. Ma la capacità di adattamento, di far fronte agli stress (o anche semplicemente alle incombenze quotidiane), la vitalità stessa vengono compromesse.
Questa situazione di ipocortisolismo relativo (l’ipocortisolismo assoluto coinciderebbe con la malattia di Addison) può svilupparsi come risposta al suo opposto, cioè ad un’attivazione intensa o prolungata dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene dovuta a una situazione di stress molto elevato o cronico. Possiamo spiegarcela come un tentativo dell’organismo di difendersi dai danni dovuti all’eccesso di cortisolo. Oppure si può vedere come una sorta di esaurimento del corpo dopo che è stato costretto a uno sforzo eccessivo.
In ogni caso, livelli troppo bassi di cortisolo possono avere una serie di effetti che possiamo semplificare così:
- A livello metabolico: il corpo fatica a produrre energia
- A livello immunitario: aumenta lo stato di infiammazione
- A livello nervoso: eccessiva attivazione del sistema simpatico, responsabile della reazione di allarme in caso di stress. Questo è dovuto al fatto che il cortisolo esercita un feedback negativo sul sistema nervoso simpatico (elevati livelli di cortisolo ne riducono l’attivazione), e quando è troppo basso questa regolazione viene meno.
Questi effetti corrispondono a tre sintomi tipici dell’ipocortisolismo: spossatezza, dolore, tensione emotiva e ipersensibilità allo stress.
In linea con questo, bassi livelli di cortisolo sono stati osservati in molti pazienti affetti da:
- Sindrome da stanchezza cronica e fibromialgia. Entrambe queste sindromi sono caratterizzate da spossatezza e dolore, mentre a livello biochimico sono stati riscontrati un elevato livello di infiammazione e bassi livelli di cortisolo.
- Disturbo da stress post traumatico. In questo caso i sintomi sono prevalentemente di tipo psicologico; a livello fisiologico si osservano un’eccessiva attivazione del sistema simpatico ed elevati livelli di infiammazione.
- Burnout. La sindrome da burnout è l’esempio per eccellenza dell’esaurimento psicofisico che può seguire un lungo periodo di fortissimo impegno.
- Long COVID. Nella fase acuta dell’infezione si verifica un’ipersecrezione di cortisolo, dopodiché nel long COVID i livelli dell’ormone risultano eccessivamente bassi. La sintomatologia si sovrappone in larga misura con quella della sindrome da stanchezza cronica.
- Artrite reumatoide. Nella genesi di questa malattia infiammatoria è implicata un’insufficiente azione antinfiammatoria del cortisolo.
Stress? Stanchezza? PROVA
I RAPIDISSIMI ENERGY UOMO e I RAPIDISSIMI ENERGY DONNA!
MULTIVITAMINICO per l’UOMO
13 Vitamine + GINSENG!
MULTIVITAMINICO per la DONNA
13 Vitamine + ELEUTEROCOCCO!
Fonti scientifiche
Agorastos, A., & Chrousos, G. P. (2022). The neuroendocrinology of stress: the stress-related continuum of chronic disease development. Molecular Psychiatry, 27(1), 502-513. https://doi.org/10.1038/s41380-021-01224-9
Janssen, J. A. (2022). New insights into the role of insulin and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) Axis in the metabolic syndrome. International journal of molecular sciences, 23(15), 8178. https://doi.org/10.3390/ijms23158178
Kline, S. A., & Mega, M. S. (2020). Stress-induced neurodegeneration: the potential for coping as neuroprotective therapy. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias®, 35, 1533317520960873. https://doi.org/10.1177/1533317520960873
Tanriverdi, F., Karaca, Z., Unluhizarci, K. Ü. R. Ş. A. D., & Kelestimur, F. (2007). The hypothalamo–pituitary–adrenal axis in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia syndrome. Stress, 10(1), 13-25. https://doi.org/10.1080/10253890601130823
Adam, E. K., Hawkley, L. C., Kudielka, B. M., & Cacioppo, J. T. (2006). Day-to-day dynamics of experience–cortisol associations in a population-based sample of older adults. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(45), 17058-17063. https://doi.org/10.1073/pnas.0605053103
Fries, E., Hesse, J., Hellhammer, J., & Hellhammer, D. H. (2005). A new view on hypocortisolism. Psychoneuroendocrinology, 30(10), 1010-1016. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2005.04.006
Kakiashvili, T., Leszek, J., & Rutkowski, K. (2013). The medical perspective on burnout. International journal of occupational medicine and environmental health, 26, 401-412. https://doi.org/10.2478/s13382-013-0093-3
Yavropoulou, M. P., Tsokos, G. C., Chrousos, G. P., & Sfikakis, P. P. (2022). Protracted stress-induced hypocortisolemia may account for the clinical and immune manifestations of Long COVID. Clinical Immunology, 245, 109133. https://doi.org/10.1016/j.clim.2022.109133
Yavropoulou, M. P., Filippa, M. G., Panopoulos, S., Spanos, E., Spanos, G., Tektonidou, M. G., & Sfikakis, P. P. (2022). Impaired adrenal cortex reserve in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases who relapse upon tapering of low glucocorticoid dose. Clinical and Experimental Rheumatology, 40(9), 1789-1792. https://doi.org/10.55563/clinexprheumatol/x78tko
Ti è piaciuto questo articolo? Allora fallo leggere anche ai tuoi amici!
Condividilo sui social e metti un “mi piace” al nostro profilo!